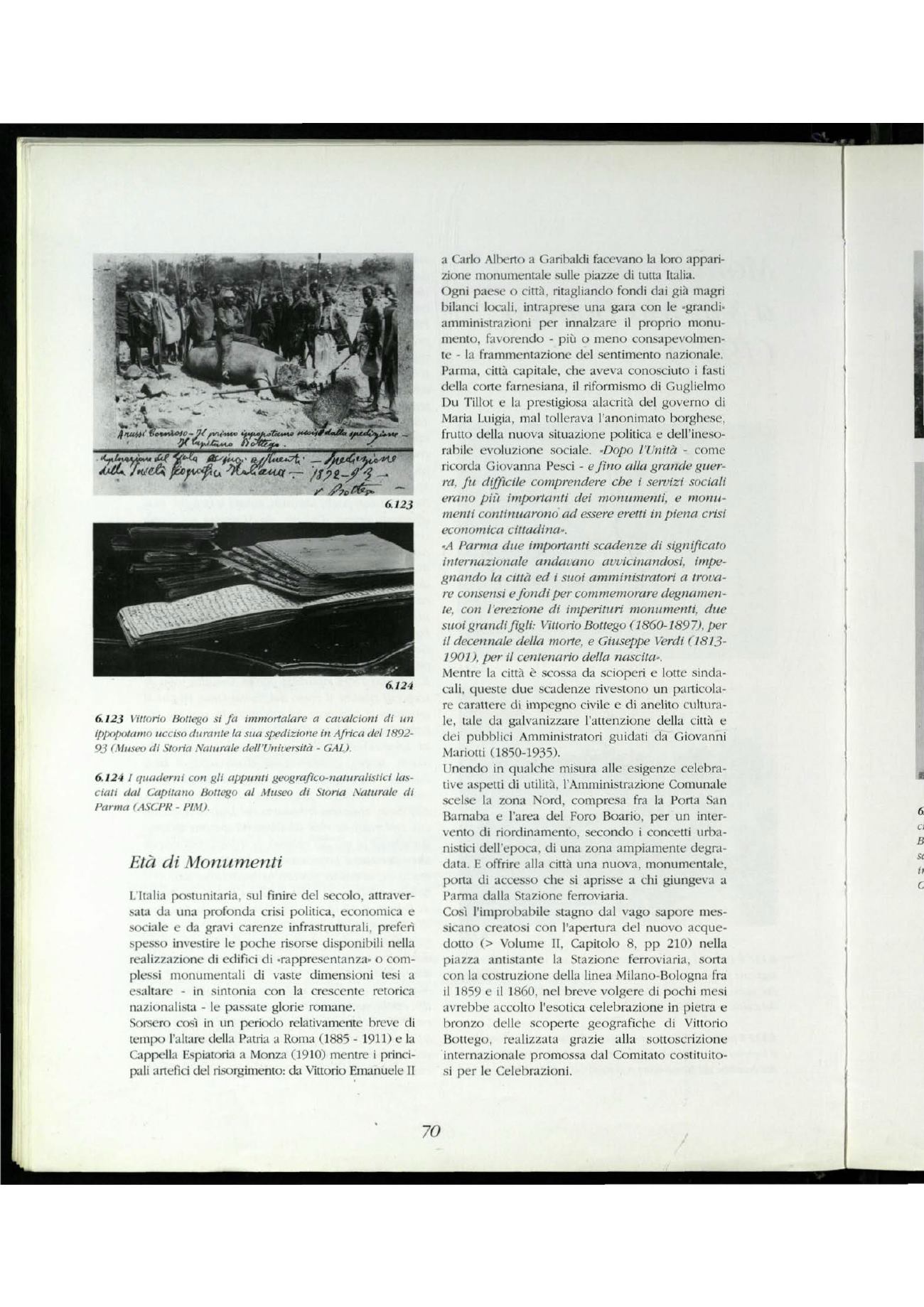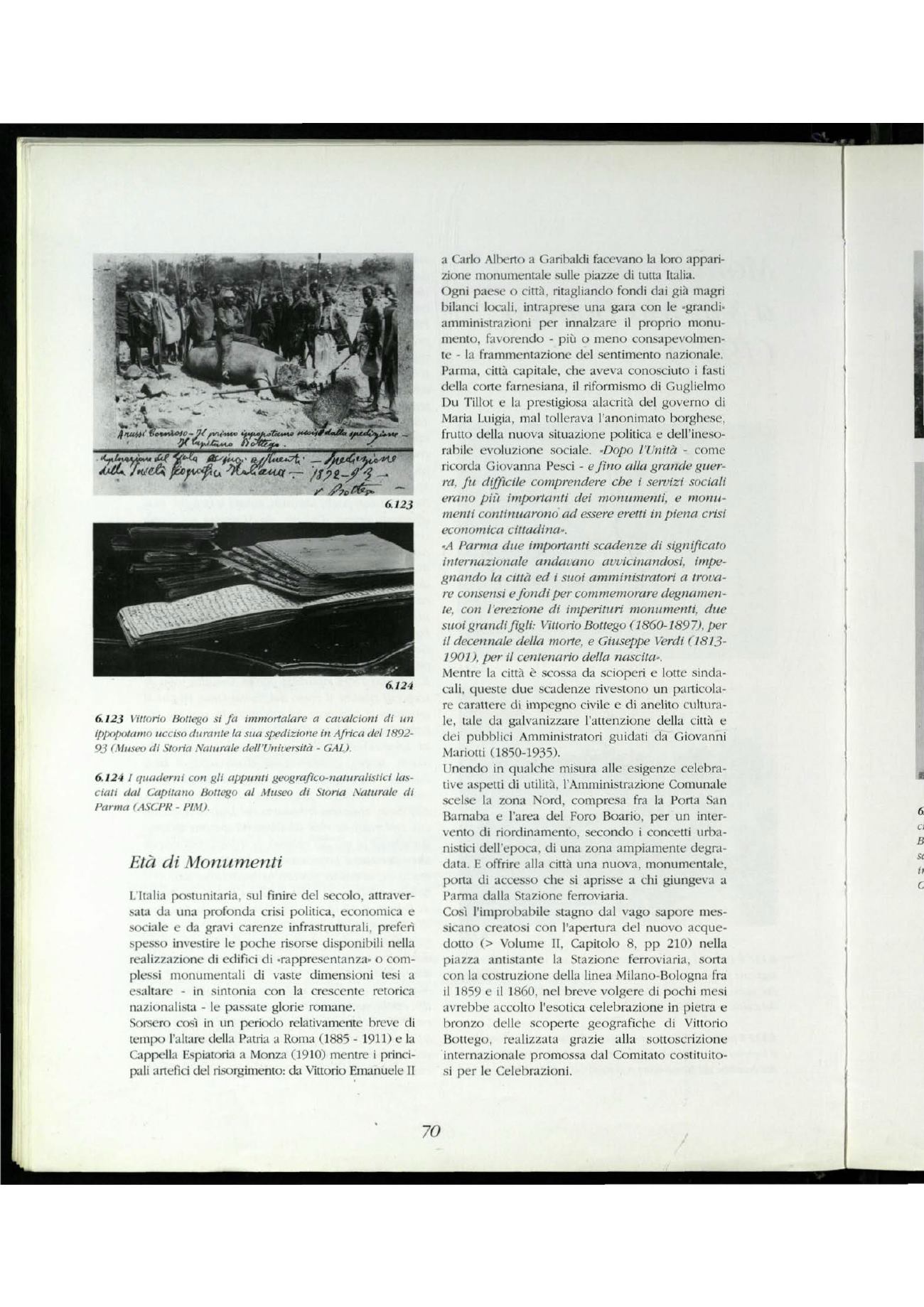
6. 124
6. 123
VilfOI'iO Bolfego si
jt1
immorttllare a cavalcioni di
1111
tppopowmo ucciso durt111te la sua spedizione in Africa del 1892-
93 (JHm·(,'O di Storia Natttmle dell'Università
-
GAL).
6.
l
24
l
con gli appunti geografico-naturctlistici ltts-
citltl dt1l Copitano Bot/ego al Museo
eli
Sto!'ICI Naturcile di
Parmt1 (ASCPR
-
PIM).
Età di Monumenti
L'Iralia postunitaria, sul finire del ecolo, attraver-
sata da una profonda crisi politica, economica e
·ociale e da gravi carenze infrastrutturali, preferì
spesso investire le poche risorse di ponibili nella
realizzazione di edifici di •rappresentanza· o com-
plessi monumentali di vaste dimensioni tesi a
esaltare - in sintonia con la crescente retorica
nazionalista - le passate glorie romane.
orsero così in un periodo relativamente breve di
tempo l'altare della Patria a Roma (1885- 1911) e la
Cappella Espiatotia a Monza (1910) mentre i princi-
pali artefici del risorgimento:
da
Vittorio Emanuele
11
a Carlo Alberto a Garibaldi facevano la loro appati-
zionc monumentale sulle piazze di
tutta
Italia.
Ogni paese o città, ritagliando fondi dai già magri
bilanci locali, intraprese una gara con le ·grandi·
amministrazioni per innalzare
il
proprio monu-
mento, favorendo - più o meno consapevolmen-
te - la frammentazione del sentimento nazionale.
Parma, città capitale, che aveva conosciuto i fasti
della corte farnesiana ,
il
riformismo di Guglielmo
Ou Tillot e la prestigiosa alacrità del governo di
Maria Luigia, mal tollerava l'anonimato borghese,
fruuo della nuova situazione politica e dell'ineso-
rabile evoluzione sociale.
"Dopo l'Unità
-
come
ricorda Giovanna Pesci -
e fino alla grande guer-
ra, fu dij]ìcile comprendere che i servizi sociali
eremo piìt importanti dei monumenti, e monu-
menti continuarono ad essere eretti in piena crisi
economica cilladina·.
·A Parma due importanti scadenze di significato
internazionale andavano avvicinandosi. impe-
gnando la cillà ed
i
suoi amministratori a lrova-
re consensi e fondi per commemorare degnamen-
te, con l'erezione di imperituri monumellli, due
suoi grandifigli: Vii/orio Bottego (1860-1897), per
il decennale della mo11e. e Giuseppe Verdi (1813-
1901), per il centenario della nascita•.
Mentre la città
è
scossa da scioperi e lotte sinda-
cali, queste due scadenze rivestono un particola-
re carattere di impegno civile e di anelito cultura-
le, tale da galvanizzare l'attenzione della città e
dei pubblici Amministratori guidatj da Giovanni
.Mariotti (1850-1935).
70
Unendo in qualche misura alle esigenze celebra-
live aspetti di utilità, l'Amministrazione Comunale
scel e la zona ord, compresa fra la Porta an
Barnaba e l'area del Foro Boario, per un inter-
vento di riordinamento, econdo i concetti urba-
ni tici dell'epoca, di una zona ampiamente degra-
data. E offrire alla città una nuova, monumenrale,
porta di acces o che si aprisse a chi giungeva a
Parma dalla razione ferroviaria.
Così l'improbabile stagno dal vago sapore mes-
sicano creatosi con l'apertura del nuovo acque-
dotto
(>
Volume II, Capitolo 8, pp 210) nella
piazza antistante la razione ferroviaria, sorta
con la costruzione della linea Milano-Bologna fra
il
1859 c il 1860, nel breve volgere di pochi mesi
avrebbe accolto l'esotica celebrazione in pietra e
bronzo delle scoperte geografiche di Vittorio
Bottego, realizzata grazie alla sottoscrizione
internazionale promossa dal Comitato costituito-
si per le Celebrazioni.
6
Cl
8
s
i